Due sono le massime fondamentali in cui si condensa il lascito spirituale di Siddharta, il più noto romanzo di Hermann Hesse, edito nel 1922. La prima: «La scienza si può comunicare, ma la saggezza no». La seconda: «L’amore mi sembra di tutte la cosa principale». Tuttavia, con buona pace del dono della sintesi, è bene spendere più di qualche parola per chiarire fino in fondo il senso di questi assunti, che è lampante solo in apparenza.
Si rende quindi necessaria una breve introduzione sul retroterra culturale – teoretico, anzi – del romanzo. Hesse ben conosce l’idealismo tedesco di Hegel e Schopenhauer; né gli mancano competenze più che basilari sulle dottrine buddiste. Conosce, poi, i profondi legami che intrecciano strettamente le due correnti di pensiero, in apparenza così distanti. Entrambe le dottrine, infatti, fanno leva sulla natura illusoria del mondo sensibile. Il concetto di maya, illusione, presente nel culto brahminico, compare nel pensiero occidentale sotto forma di velo di Maya: la nota metafora con cui Schopenhauer indica l’illusorietà di tutto ciò che possiamo vedere, toccare, sentire e che comunemente scambiamo per realtà. Altro punto in comune tra le due dottrine – che consegue dal primo – è la consapevolezza dell’esistenza di una dimensione spirituale ultrasensibile. A tal proposito, Hegel fa riferimento al «salto nell’Assoluto», inteso come passaggio da Verstand, comune raziocinio dell’intelletto pratico, a Vernunft, dominio dei concetti puri. Lo stesso concetto già compare nel buddismo come passaggio da Samsara a Nirvana: dall’eterno ciclo di reincarnazioni che imprigiona le anime all’agognato vuoto materiale e sensibile, che è una dimensione puramente contemplativa.

Tutto ciò significa che le inquietudini che agitano il cuore di Siddharta, vissuto nel V secolo a.C., sono – almeno in parte – le stesse che turbano gli idealisti tedeschi del XIX secolo, e in particolare: come conseguire una conoscenza autentica? Come pervenire alla comprensione finale, completa, definitiva del mondo e dell’Io? Come evitare di rimanere imbrigliati tra le maglie del velo di Maya, dell’illusione, senza mai conoscere alcunché di vero? Le speculazioni di Siddharta ruotano intorno a tale quesito, che costituisce il punto di partenza e di arrivo del suo itinerario di crescita spirituale.
Un itinerario che, come vedremo, si articola in più fasi. Siddharta ha la fortuna di appartenere, per nascita, al ceto più elevato del sistema di caste: è figlio del Brahmino, sacerdote di Brahma. La società indiana, articolata in base a uno schema rigidamente piramidale, si suddivide infatti in più fasce: in cima c’è la casta dei Brahmini, letteralmente i nati due volte, che secondo il mito sono stati generati dalla testa del dio Brahma. Seguono i Kshatrya, guerrieri e principi, usciti dalle braccia di Brahma; i Vaicya, contadini e mercanti, usciti dal ventre di Brahma; e infine i Sudra, umili manovali, usciti dai piedi di Brahma. Esterni alla casta ci sono poi i Paria, gli indegni, che non meritano nemmeno di esistere. Appare subito chiaro, dunque, come Siddharta sia avviato sin da bambino a una vita agiata, e a incarnare, una volta adulto, la vocazione sacerdotale del padre. Egli tuttavia, stanco del continuo reiterarsi dei riti brahminici, che gli appaiono privi di senso, prende una decisione radicale, in netta opposizione con la volontà paterna: diventare un Samana, un meditatore, un asceta che si spoglia di ogni bene materiale per abbracciare la povertà e la vita nei boschi – in maniera non troppo dissimile da Francesco d’Assisi, che compie la medesima rinuncia al mondo di opulenze cui era abituato per abbracciare la «vita dello spirito». Siddharta, infatti, non è soddisfatto del modo in cui la dottrina di Brahma propone di realizzare la comunione tra umano e divino; la chiave, egli crede, è nella meditazione. Così si unisce ai Samana, per praticare con loro l’ascesi e la spersonalizzazione, la totale rinuncia a ogni esercizio dei sensi.
E tuttavia, anche dal modo di vivere dei Samana rimane deluso: «Mille volte Siddharta poteva sfuggire dal suo Io: inevitabile era il ritorno, inesorabile l’ora in cui egli ritrovava se stesso, ed era di nuovo l’Io-Siddharta, e di nuovo provava il tormento di non poter sfuggire al circolo delle trasformazioni. […] La stessa evasione, lo stesso effimero stordimento prova il bovaro all’osteria, quando si tracanna alcuni bicchieri di acquavite o di latte di cocco fermentato.» Si tratta ovviamente di una condizione effimera e inautentica, tanto da spingere il giovane ad affermare: «Ma il Nirvana non lo raggiungeremo: non lo raggiungerà il maestro, non lo raggiungeremo noi». Siddharta ha dunque compreso che l’ascesi dei Samana non apre al sentiero per la conoscenza dell’Io; così, ben presto, se ne allontana. Con lui c’è l’amico Govinda, cui è unito da sincero affetto sin dalla più tenera infanzia e che fino ad ora ha condiviso il suo percorso spirituale. Le loro strade, infatti, sono destinate a dividersi: decisivo sarà l’incontro con Gotama, il Buddha, suprema autorità spirituale. Egli è l’unico che sia riuscito a spezzare la Samsara, la continua catena di incarnazioni e reincarnazioni, e a raggiungere così il Nirvana, la perfetta contemplazione e la pace dei sensi.
Quando lui e Govinda si troveranno ad assistere alla predicazione di Gotama, infatti, Siddharta non subirà la fascinazione cui restano soggetti tutti gli ascoltatori. Al contrario, egli assumerà un atteggiamento critico nei confronti del dettato di Buddha: «Una cosa non contiene questa dottrina: non contiene il segreto di ciò che il Sublime stesso ha vissuto, egli solo fra centinaia di migliaia. Questo è ciò di cui mi sono accorto, mentre ascoltavo la dottrina. Questo è il motivo per cui continuo la mia peregrinazione: per abbandonare tutte le dottrine e tutti i maestri e raggiungere da solo la mia meta o morire. […] Se io diventassi ora uno dei tuoi discepoli, [il mio Io] continuerebbe a vivere e a ingigantirsi, poiché lo materierei della dottrina».
Qui veniamo alla prima delle massime citate in apertura: «La scienza si può comunicare, ma la saggezza no». Siddharta ha compreso che apprendere e praticare una dottrina non equivale a vivere in prima persona il mistero dell’Illuminazione. Ed è esattamente questo il suo obiettivo: vivere il Nirvana, non studiarlo, non tentare invano di raggiungerlo seguendo i principi imposti da altri. È questo, per Siddharta, il momento del «Risveglio», che chiude la prima parte del romanzo: «Stabilì che non era più un giovinetto, ma era diventato un uomo. […] Una cosa non era più presente in lui: il desiderio di avere maestri e di conoscere dottrine». È tale desiderio che lo spinge a lasciarsi ogni cosa alle spalle, e ad affermare con convinzione: «Dal mio stesso Io voglio andare a scuola, voglio conoscermi, voglio svelare quel mistero che ha nome Siddharta».
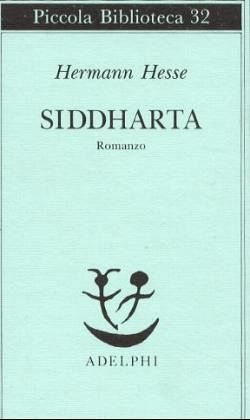
Finalmente, il giovane ha compreso che la totale rinuncia alla realtà, al mondo dei sensi, predicata tanto dai culti brahminici della sua infanzia quanto dall’ascetismo sterile e mortificante dei Samana, è inutile. Altrettanto inutile è praticare sempre gli stessi riti, nella speranza di cogliere ciò che è destinato a sfuggire in eterno a chiunque pensi di poterlo cogliere mediante la dottrina. Eppure, bisogna sperimentare, e bisogna meditare: «Belle cose l’una e l’altra, il senso e i pensieri. Entrambe occorreva esercitare, entrambe bisognava guardarsi dal disprezzare o dal sopravvalutare». A questo punto, Siddharta è pronto per tuffarsi nella materialità che aveva sino allora respinto. Così, inizia a vivere nel mondo, «tra gli uomini-bambini», coloro che si affannano tra fatiche quotidiane e piccoli drammi senza peso, e che Siddharta osserva dall’alto in basso con gli occhi di un Samana. Egli apprende da Kamala, bellissima cortigiana, i piaceri dell’amore; e da Kamaswami, ricco mercante, i segreti del commercio. Anni dopo, Siddharta è un opulento mercante, circondato di ballerine succinte e di servi fedeli. Qui appare evidente il suo radicale cambiamento: se prima il «gioco degli uomini», le donne, gli affari, le ricchezze, lo avevano interessato solo marginalmente, in modo distaccato, ora ne è completamente assorbito. Egli non è più un Samana, ma un commerciante ricco e avido, un giocatore d’azzardo sfrenato, che non si fa scrupolo di dilapidare il suo patrimonio. «La ruota dell’ascetismo, la ruota del pensiero, la ruota dell’isolamento aveva ancora a lungo continuato a vibrare, vibrava ancora, ma lentamente indugiava ed era ormai prossima allo stato di quiete. […] Il mondo e la pigrizia erano penetrati nell’animo di Siddharta».
Toccato il fondo, Siddharta comprende che può solo soccombere. Si allontana nottetempo dalla città, e giunto in riva a un fiume medita il suicidio. Nell’attimo fatale, però, gli risuona nel cuore l’Om, la Perfezione, la sillaba sacra: è il suono della voce che negli ultimi anni aveva perso, che si era affievolita sino a scomparire. Egli è ora pronto per iniziare una nuova vita, in riva al fiume. Sarà allora che, per vie traverse, scoprirà l’autentico significato dell’amore; il fatto che esso sia il principio unificante del Tutto. Veniamo qui alla seconda massima d’apertura: «L’amore mi sembra di tutte la cosa principale». Tuttavia, gli sarà possibile comprenderlo solo dopo aver fatto esperienza dell’amore. Del resto, già in gioventù, rifiutando di accogliere passivamente la dottrina di Buddha, aveva intuito che l’Illuminazione può solo essere vissuta, ma non spiegata.
La prima edizione italiana dell’opera, per i tipi di Adelphi, è del 1945. Al 1972 risale invece la sua unica, e non molto fortunata, trasposizione cinematografica. In quanto romanzo di formazione, Siddharta conosce un’inaspettata fortuna tra i giovani, soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta. È allora che viene fatto ampio uso da parte dei movimenti giovanili della metafora dell’amore, stravolta rispetto alla formulazione originale. Se infatti la cultura hippie riduce troppo spesso la parabola dell’amore come principio universale al mero esercizio della libertà sessuale – e nel migliore dei casi, a un ideale di fratellanza tra i popoli – quel che si trova in Siddharta è una definizione dell’amore come esperienza relazionale, ma soprattutto trascendente; come pratica di meditazione capace di liberare le coscienze dai tumulti interiori e dalla sterile materialità dell’esistenza terrena, per portare in esse la pace dell’Om.
La peculiarità di questo romanzo è che i suoi lasciti sono molteplici. Ognuno può trovarci una parte di sé, ognuno può darne una diversa interpretazione. Ma ciò che sicuramente si può trovare tra le sue pagine è un senso di pace. Vivere il percorso di Siddharta fianco a fianco con lui stimola, nel lettore più attento, un forte senso di empatia: si ha la sensazione di vivere in prima persona le fasi di questa crescita spirituale. È soprattutto questo a rendere l’opera di Hesse carica di un significato immortale, che gli ha consentito di diventare un piccolo cult e di imprimersi nella memoria collettiva, resistendo all’alternarsi delle mode letterarie.
