Trentacinque album in studio come solista, tredici firmati assieme alla storica band Van der Graaf Generator, e infinite performance dal vivo. È la mera summa numerica della carriera ormai cinquantennale del cantante e compositore Peter Hammill, nota icona del progressive rock inglese più atipico. Nato proprio il 5 novembre di settant’anni fa nel quartiere londinese di Ealing, la sua produzione non solo non ha conosciuto un momento di arresto, ma ha anche preso innumerevoli cambi di direzione, talvolta imprevedibili. Un percorso che continua tutt’oggi, sia con dischi in studio sia con performance dal vivo che toccano un po’ tutto il centro Europa e che si estendono anche fino al Giappone. Servirebbero libri interi per ripercorrere una carriera così vasta e densa. Ma questo settantesimo compleanno sembra l’occasione giusta per celebrare quel rinnovamento che, dopo un netto periodo di crisi, ha portato Peter Hammill a una nuova, straordinaria, consapevolezza artistica.
Peter Hammill malinconico cantautore di galassie lontane
Peter Hammill muove i primi passi da artista nel 1969, quando fonda il gruppo progressive rock Van der Graaf Generator. L’esperienza col Generatore e il rapporto con gli altri membri del gruppo sarà un punto di riferimento indispensabile (sia personale che musicale), anche nelle numerose occasioni in cui verrà sciolto (e successivamente ricomposto). Le fondamenta su cui poggiano le sonorità dei VdGG sono quelle del progressive rock, ma vengono eseguite e distorte in una chiave alienante, mistica ed esistenziale. L’organo di Banton in sottofondo, i giri di sax di Jackson, i cambi di ritmo schizofrenici, e poi ovviamente l’ugola di Hammill; il tutto ci porta in una dimensione strana e lontana, qualcosa che non ti aspetti di sentire sul pianeta Terra. Una voce incredibilmente flessibile la sua, una giostra che alterna tonalità celestiali a urla demoniache, il tutto condito da uno stile barocco ricco di sonorità deflagranti, su cui confluisce il fiume di parole che escono dalla penna di Hammill. Il barocco spesso si unisce al teatrale, tanto nell’impostazione vocale quanto nell’estetica del gruppo e delle loro apparizioni dal vivo. Come Pascal proponeva una filosofia umana ed esistenziale nel momento in cui la filosofia era tutta incentrata sul meccanicismo cartesiano, i VdGG ignorano ogni tecnicismo e virtuosismo del progressive rock e si lasciano sprofondare nella malinconia cosmica.

Parlare della lirica hammilliana significa parlare di solitudine, del rapporto tra l’io e il tutto, della caducità umana, e di intima consapevolezza tanto dei propri limiti quanto delle proprie aspirazioni. Ma queste sarebbero solo etichette e non renderebbero giustizia a un capacità di scrittura davvero illimitata e sempre pronta a trovare figure retoriche, espedienti narrativi, citazioni letterarie per riuscire a esprimere quello che in molti proviamo ma in pochi riescono a dire. L’Uomo hammilliano è una figura perennemente in bilico, che non ha paura di ammettere di avere paura. In questo sta il suo tratto più squisitamente umano. Con una formula diventata classica, l’io è contemporaneamente «killers, angels, refugees». Impossibile non cogliere anche il gusto (neo)romantico di molti pezzi dei Van der Graaf: dai terrificanti immaginari post apocalittici di Darkness (11/11) alla schizofrenica suite-capolavoro A plague of lighthouse keepers che ci catapulta nel mezzo di una tempesta esistenziale tra navi mai salpate e i fantasmi della solitudine. Dove il progressive rock (o almeno una sua parte consistente) di questi anni sembra volerci portare in immaginari luoghi fiabeschi, il Generatore ci prende per mano e ci guida all’esplorazione di magnifiche galassie lontane.
1969-1999: gli esordi, le sperimentazioni e la stagnazione
Hammill esordisce da solista con Fool’s mate (1971), una raccolta di composizioni per piano/chitarre e voce molto più vicine al songwriting tradizionale. Seguono poi una manciata di dischi suonati coi membri del gruppo appena scioltosi, nei quali riprende alcune sonorità più squisitamente progressive unendole a una differente sensibilità, talvolta vicina all’art rock, altre volte di stampo prettamente gotico. Esemplare in questo senso è l’oscuro e sacrale The silent corner and the empty stage (1974). L’anno successivo è il tempo di Nadir’s big chance, un imprevedibile disco proto-punk che anticipa di non poco quello che sarà il grande movimento punk di pochi anni in avanti. Il 1976 è l’anno del suo capolavoro Over, una struggente raccolta di canzoni scritte per superare un trauma amoroso. I ricchi arrangiamenti, a cui a volte si aggiungono perfino degli archi, e il grande pathos nell’impostazione vocale, conducono a un’esperienza emotiva unica e travolgente. Il seguito The future now cambia totalmente rotta, lanciandosi sulla strada della sperimentazione con intuizioni di new wave, il tutto spesso condito da un uso straniante dei sintetizzatori.
Gli anni ’80 sono un periodo di sperimentazioni: nello stesso 1980 esce Black box che lo vede all’opera anche alla batteria, con un risultato a volte non pienamente riuscito ma tutto sommato dignitoso. Decide poi di formare un gruppo con altri tre ex membri degli allora sciolti Van der Graaf Generator formando il K Group. Il risultato è uno spiazzata Enter K che ri-assembla le sonorità della new wave più graffiante, e il successivo Patience, che contiene alcuni dei classici più famosi delle sue esecuzioni in live (in primo luogo Traintime). Il 1983 è anche l’anno dello sperimentale Loops and Reels dove Hammill si diverte a stratificare suoni e loops ottenendo un’affascinante atmosfera dal gusto tribale. Fino a qui l’asticella è rimasta altissima a ogni produzione, ed è incredibile vedere con quale abilità Hammill sia riuscito a percepire le novità imminenti e a riarrangiarle in una chiave più vicina alla sua vena artistica.
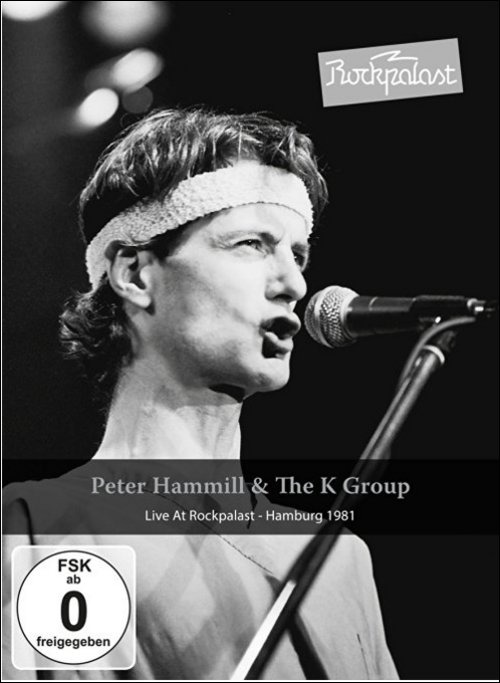
Successivamente però la carriera di Hammill comincia a perdere evidentemente colpi. Nel discreto Skin (1986) possiamo trovare pezzi degni di nota, come la minimale ballata Four pails una grandiosa presa di coscienza della propria contingenza, cristallizzata nella metafora dei “quattro pali” («Four pails of water and a bagfull of salts / That is all we are, that is all a man comprises»). Ma la penna hammiliana sembra cominciare a incepparsi e si accumulano una manciata di album poco incisivi e del tutto dimenticabili (Out of the water, In a foreign town). Salvo alcune eccezioni come l’interessante rock-opera The Fall of the House of Usher (tratta da un racconto di E. A. Poe) e il minimale Fireships, la verve creativa sembra perdersi disco dopo disco. Forse il punto più basso degli sfortunati anni ‘90 è rappresentato dall’elettronica mal riuscita di The noise, ma la sensazione generale è che si stia andando a perdere tanto la forma quanto la sostanza. Anche quando si presenta con idee fresche e sperimentali, come nell’onirico Sonix (che riprende un po’ il lavoro del precedente Loops and reels), sembra mancare il bersaglio. Altro disco che sembra avere le carte in tavola per segnare un nuovo punto di partenza è Everyone you hold, che contiene la bellissima Bubble, ma nient’altro di rilevante. L’attività artistica di Hammill sembra ritorcersi su sé stessa: quando cerca di fare bene quello che sa fare bene, come le composizioni in piano e chitarra, sembra sempre mancare il punto, oscillando tra il noioso e lo scontato. Quando invece si lancia in progetti più sperimentali non riesce a renderli coesi con il suo stile di cantautorato. Anche a livello di scrittura sembra che la vena poetica surreale e trascendente degli anni ‘70 si sia persa, e anche la melanconia delle sue ballate non sembra avere il pathos necessario a smuovere gli animi.
2000-2018: la rinascita del qui e ora
Gli inizi del nuovo millennio sembrano seguire questa falsariga: None of the above e What now? riscaldano una pietanza ormai poco appetitosa, e pure lo strumentale Unsung, con qualche interessante intuizione no wave, appare piuttosto insipido. Se l’attività in studio è abbastanza sfortunata, non si può certo dire lo stesso di quella dal vivo: la fine degli anni ‘90 e gli inizi del 2000 sono l’occasione di alcune performance live migliori del nostro artista, molte delle quali raccolte nel doppio disco Typical, contenente alcune delle migliori revisioni dei pilastri discografici hammilliani.
Nel 2002 questa decadenza sembra, se non invertirsi, perlomeno arrestarsi: Clutch è un disco più fresco dei precedenti e sembra colmare un po’ quei vuoti che si è lasciato attorno. Un ritorno alle radici più folk e dagli arrangiamenti volutamente spogli e spigolosi, che si vanno a combinare con un’impostazione vocale più dura e roca. Non il miracolo che ci si aspettava, ma un disco sincero e discretamente confezionato.
L’anno successivo, poco prima di finire le registrazioni per un nuovo lavoro, Hammill crolla a terra per un infarto. Dopo tanti anni passati a scrivere sulla caducità della vita, toccare con mano la fine della propria esistenza è un trauma da metabolizzare con cura. Nel 2004 finisce i lavori per Incoherence, un concept album sulle difficoltà di esprimersi attraverso il linguaggio naturale, con non pochi riferimenti alla tradizione filosofica dell’antica Grecia. Una produzione più spessa e lontana dal semplice folk di Clutch, con un piacevole ritorno dell’uso di strumenti a fiato. I presupposti per l’inizio di un nuovo percorso artistico ci sono tutti, e non a caso nel 2005 decide di rifondare il gruppo del Generatore, pubblicando un doppio album. La nuova frenetica attività di Hammill trasuda l’urgenza di dover dare voce alla propria vocazione e di doverlo fare qui e ora. Perché non è scontato che più avanti ci sarà ancora il tempo per farlo.
Hammill si rimbocca le maniche, ed è già al lavoro su un nuovo disco, che prenderà il nome di Singularity. Qui ormai l’ascesa stilistica è ormai evidente: canzoni dalla forma ben definita, con nuove sonorità e un enorme lavoro di finissima produzione. L’energia ritrovata viene catalizzata da una parte in un gaudente inno alla vita, e dall’altra parte dall’urgente allarmismo di dover spendere al meglio ogni secondo a disposizione. Ritmi energici, schitarrate violente si alternano a sperimentazioni vocali ed elettroniche. Notevolissime l’imponente e teatrale Famous last word e la conclusiva White dots, con la quale Hammill si diverte a giocare con l’effettistica, sovrapponendo a più strati le voci, mandandole in reverse, il tutto su un tappeto sonoro di puro drone. Mai come ora si avverte l’urgenza del momento di esprimersi, di cogliere l’attimo e non abbandonarsi al passare degli anni. Di cose da dire ce ne sono molte, troppe forse, e vanno dette subito: questo sembra suggerirci quell’incipit di batteria dell’iniziale Our eyes give it shape. La consapevolezza di aver toccato con un dito la fine della corsa e la coscienza di doverne prenderne atto. Il seguito di Singularity si chiama Thin air ed esce nel 2009. L’asticella rimane alta anche con questo lavoro, e forse più che mai Hammill sembra strizzare l’occhio alla contemporaneità, almeno per quanto riguarda la produzione. Il disco si apre con la minimale e dai tratti vagamente post-rock Mercy, che ci conferisce fin da subito la cifra per leggere l’intero disco. Anche in questo caso è la grandissima capacità di unire intrecci vocali puliti e ariosi a fare da protagonista, unendo il tutto a un effettistica e a una produzione di tutto rispetto. C’è spazio anche per sonorità “glitchose” del breve intermezzo Wrong way round, che precede la spettrale Ghost of planes (probabile allusione al disastro delle Torri Gemelle). La chiusura con The top of the world club, poi, è semplicemente perfetta: una composizione intrisa di declino, nebulosa e rarefatta, coi suoi continui sali e scendi che procedono a spirale. Come il suo predecessore l’urgenza è quella del dramma, ma questa volta si abbandona una poetica più diretta per ritornare all’allegoria che aveva caratterizzato i primi lavori.
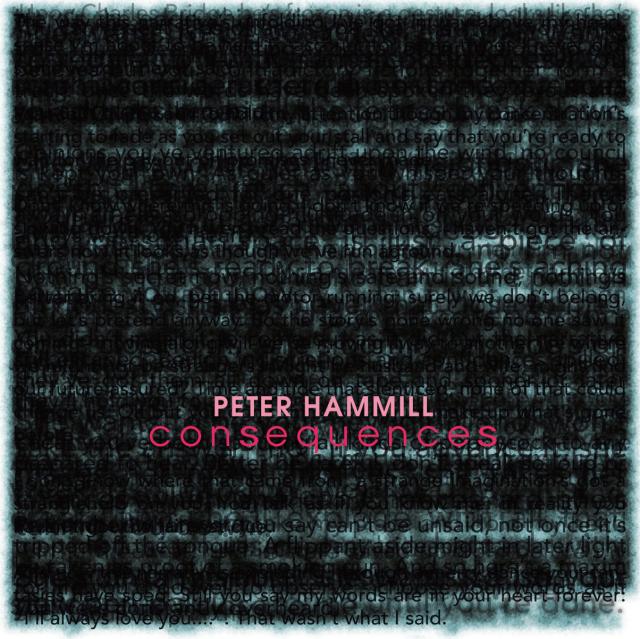
All’improvviso arriva un disco dalla confezione strana. È il 2012, il disco è Consequences e la nuova incarnazione di Hammill ci stordisce fin dalla copertina. La produzione è asettica e glaciale, un baratro di fitta oscurità che rende difficile la respirazione. I tasti del pianoforte di That wasn’t what I said sfrigolano rumorosi come un televisore che non riceve il segnale. L’intreccio di voci e contro voci di Scissors è un turbine disorientante. Ma la vera perla del disco, forse uno due migliori pezzi di Hammill degli ultimi due decenni, è la conclusiva Run of luck: una gelida esecuzione al pianoforte dove l’impostazione vocale è quanto mai carica di pathos e gravida di rimorso. Impossibile non commuoversi di fronte a una sensibilità umana così minimale e diretta, resa ancora più drammatica da quel finale lasciato in sospeso, come se l’ultimo verso non fosse stato scritto. Forse perché non poteva essere scritto. Ritorna il tema della difficoltà di comunicare attraverso il linguaggio; ma se prima questa incomunicabilità ricordava quella dei cretesi antichi, Consequences nella sua impenetrabilità ricorda più il linguaggio wittgensteiniano. Ci muoviamo anche su un piano differente dell’alienazione caratterizzante i primi lavori. Se prima l’io hammilliano faceva fatica a riconoscersi di fronte allo specchio, questa nuova incarnazione cerca di indagare l’opacità che sta dietro quello specchio.
Il futuro adesso
Forte di una collaborazione di tutto rispetto col chitarrista Gary Lucas, dalla quale è nato lo sperimentale e acido Otherworld, la carriera di Hammill sembra non avere intenzione di arrestarsi. Solo l’anno scorso è uscito From the trees, ulteriore conferma della parabola ascendente del suo percorso artistica. Questa volta Hammill decide di abbandonare le stratificazioni sonore e le complessità di produzione per tornare a composizioni di piano/chitarra e voce. Arrivato sulla soglia dei settanta Hammill sente il bisogno di fare il punto della situazione, e in questo From the trees è un disco di lucida consapevolezza della propria situazione personale e artistica. Emblematica in questo senso è la straziante Torpor, dove il cantautore non può che fare i conti con la stanchezza delle proprie membra, che giorno dopo giorno lo rallentano anche nelle azioni comuni. Questa spossatezza non gli ha impedito di lanciarsi in un tour impegnativo (che ha toccato l’Italia per ben sette date) e sembra chiaro che “rassegnazione” nella lingua di Hammill non significa abbandonarsi all’ozio. E, stando alle ultime notizie, non sembra intenzionato a fermarsi.
Quello tracciato da Hammill è un percorso indubbiamente notevole. Veterano della scena musicale, questo strano artista continua a far lavorare instancabilmente la sua vocazione. Dal punto di vista della produzione in studio i suoi dischi hanno riacquistato la forma dei tempi d’oro, e in qualche modo l’hanno anche superata, diventando opere d’arte dalla forma smussata e levigata. Un traguardo artistico che, tra le altre cose, è stato anche sancito dal conferimento della laurea honoris causa da parte del Conservatorio Nicolini di Piacenza nel 2014. Il romantico idealismo della giovinezza ha lasciato il posto a una più matura consapevolezza del reale. Se i primi dischi lasciavano trasparire una sensibilità ed espressività unica, quella sensibilità era comunque frutto di un’opera di astrazione. La scrittura degli ultimi anni, invece, tocca direttamente con mano la caducità delle cose e dell’uomo, e in primis di sé stesso. Anche le straordinarie performance dal vivo sembrano confermare questo andamento. Col passare degli anni le sue stravaganti esibizioni sono diventate più minimali nell’estetica, ma non per questo meno energiche. Hammill si presenta al pubblico come un esile e canuto signore con addosso una sobria camicia. Saluta timidamente il pubblico, appoggia un bicchiere di vino rosso sul pianoforte, si siede e comincia a suonare. Spinge ogni tasto del piano con pathos tale che non è raro che sbagli qualche nota, e non se ne vergogna affatto. Il cuore delle sue performance, e della sua carriera, sta anche in questa sua singolare imperfezione. Se è sbagliare che ci rende umani, allora Peter Hammill è il più umano di tutti noi.
