Elio Vittorini ha dovuto fare una fatica estenuante per entrare a pieno titolo nell’Olimpo della narrativa classica del Novecento. Una voce un po’ fuori dal coro, inusuale, allo stesso tempo defilata e chiassosa. Un siciliano qualunque, con una qualunque passione per la letteratura e senza alcun tipo di inclinazione allo studio, almeno di primo acchito.
Qualcuno ha sostenuto che sia stata piuttosto la sua fama come direttore de Il Politecnico ad avergli fruttato un interesse per la sua opera letteraria, e non il contrario. Qualcun altro lo individua ancora come una figura a tratti addirittura velleitaria. Col tempo è nato una sorta di “problema Vittorini”: critici e convegni sull’opera dello scrittore, prefazioni acute ai suoi lavori, dedizione e cura nell’analisi della persona. Ma grande imbarazzo nel riconoscere «Vittorini mi piace» o, di contro, «Vittorini non è per me». Certo, è sempre difficile ammettere che un classico della narrativa non ci ha conquistati o che manca all’elenco delle nostre letture – ce lo ricordò bene Calvino. Ma quanto è più strano non riuscire ad ammettere, o peggio ancora, non sapere se un autore ci ha catturati?
Elio Vittorini sull’Italia…
Parlare di Vittorini significa necessariamente ricordare tutte le contrapposizioni che lo hanno visto protagonista. La sua narrativa è senza dubbio un’alternativa. Il periodo in cui agisce è quel momento della storia letteraria in cui il narratore onnisciente dell’Ottocento non ha più motivo di essere. Da un lato si agitano i sostenitori della tradizione, della misura, di uno stile nuovo che più che guardare alle nuove frontiere della scrittura guarda ai modelli passati di Leopardi e Manzoni. Dall’altro alcuni tra i solariani, come Ojetti, Cajumi, Pavese, individuano in certi modi di scrivere delle tendenze obsolete e per questo inadatte. Vale a dire che, dopo la scoperta delle scienze sociali e della psicanalisi, a nulla poteva servire una figura regolatrice che dall’alto della sua totale conoscenza potesse esprimere con assoluta certezza l’andamento di vicende e sentimenti.
Questo è il periodo in cui si leggono Joyce, la Woolf e Proust, in cui Bergson ha introdotto la sua concezione di percezione e memoria. Questo è il periodo in cui si traducono più che mai i libri stranieri: Pavese infatti parlerà degli anni Trenta come del decennio delle traduzioni.

… e sull’America
Anche Elio Vittorini si dedica alla traduzione. In particolare, negli anni in cui opera, il cinema e il Nobel a Lewis avevano introdotto in Italia la cultura americana. E proprio Americana (1942) è il titolo dell’antologia in cui lo scrittore tenta di dare ai lettori una sorta di storia del mito dell’America. Nella sua passione verso il nuovo continente e nella sua passione verso la letteratura che questo produce, non sono pochi a vedere anche una appropriazione di un nuovo stile. Effettivamente, se si guarda a Uomini e no (1945) non è difficile ritrovare uno stile molto più americano che italiano. Vittorini usa una prosa molto spezzata, poche lambiccature retoriche, più che mai il gusto è quello per un dettato piano e asciutto. Alcune frasi ritornano spesso, come un motivo:
«Da quando sono nata?»
«Dall’inverno che sei nata».
«Perché sai quando sono nata?»
«Non me l’hai detto tu? Tu me l’hai detto».
«Mi dispiace di avertelo detto».
«Non devi dispiacerti. Perché devi dispiacerti?»
È questa una prosa non tanto lontana dallo stile di Hemingway, che chiaramente Vittorini conosce bene. Sarebbe però un errore rintracciare in questo dettato una mancanza di perizia. O, peggio ancora, sarebbe un errore rintracciarvi un’abbondanza di perizia, tutta tesa ad un fastidioso intento mimetico. Due sono le ragioni fondamentali. La prima, si è detto, è che nel panorama italiano desolante non si avevano altri appigli se non gli scrittori americani. Stanco e debilitato da quel realismo psicologico che tanto odia e che per tanto tempo ha imperversato, è immediato per Vittorini guardare a modelli come Faulkner, Hemingway, Gertrude Stein. D’altra parte, sempre rifacendoci a Uomini e no, i corsivi del romanzo raggiungono livelli di lirismo indiscutibili.
«Questo, tra i deserti, è il più squallido: non di una vita che manca, ma di una vita che non è tale. Avevi sete, e tu puoi bere; l’acqua c’è. Avevi fame e puoi mangiare; il pane c’è. C’è la fonte e i palmizi intorno, simile a quello che cercavi. Ma è solo simile alla cosa, non è la cosa. Che volevi? io mi dico. Mangio, ed è terra che mangio, non pane. Bevo, ed è terra che bevo. […] L’uomo ricorda la sua sete. Oh sete! io penso. Mi sono dissetato, ma ho ancora sete; io non ho che sporcato la mia sete. E chino sul letto bevo. Penso che sono umile in questo, penso che sono inginocchiato; ma so che la mia ferocia era la mia purezza».
La purezza e la ferocia sono quasi come delle categorie, che Vittorini ha interamente derivato dagli scrittori americani e dall’analisi dei loro scritti. Aveva riconosciuto come Emerson e Thoureau avessero gettato in America le basi per la purezza e la ferocia. Avevano infatti, loro per primi, superato finalmente gli europei, dicendo qualcosa che prima in Europa non esisteva. Era terminato, con loro, quel processo di assimilazione o appropriazione della coscienza europea in seno alla creazione della cultura americana. Nell’indagare l’uomo avevano però tralasciato una parte: quella del male. Cosa c’è nell’uomo di marcio e di vergognoso? Lo avevano cercato di scoprire per primi Poe, Hawthorne e Melville. E tutti e tre avevano scoperto che non si giunge alla purezza, se non per tramite della ferocia.
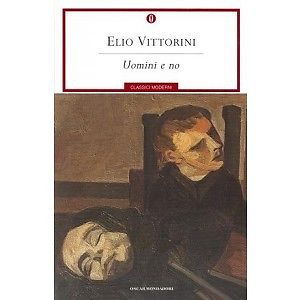
Un’alternativa al gusto italiano
Non era quello il tempo adatto per ammettere che in Italia comandava ancora un gusto desueto. Questo è il motivo alla base della censura fatta dal fascismo ad Americana. Non solo un’indagine così pedissequa equivaleva a un’ammissione di inferiorità della letteratura italiana, ma veniva apprezzato persino anche il linguaggio della scuola americana. Quel modo di procedere barbaro, che assolutamente ignorava la tradizione italiana, arrivava peraltro da un’America simbolo di corruzione e di ferocia, e aveva addirittura trovato un seguito in Vittorini, che si era per giunta messo ad imitarlo.
Le problematiche che stanno in seno all’indagine su Vittorini derivano tutte dalle contrapposizioni interne ed esterne allo scrittore stesso. Lui aveva posto sé stesso, assieme ad altri, come un’alternativa a quelle produzioni antiche che vigevano in Italia. Aveva indicato l’America come una sorta di nuovo Oriente favoloso e desiderabile. Aveva addirittura ricercato uno stile che non fosse misurato, come la rivista letteraria La Ronda proponeva, ma che fosse oltremisura: che contemperasse al suo interno poesia e prosa.
Rimane ancora aperto il problema Vittorini, dunque, dopo anni ricchi di critiche e convegni. Non è questa la sede per azzardare presuntuosamente delle motivazioni. Che sia colpa del regime, che sia colpa dell’America o di un’Italia troppo autoreferenziale; o che sia colpa dei lettori, delle traduzioni, della lingua; che sia colpa di Croce, di un dibattito culturale che si pone domande sbagliate. L’unica cosa che si sa su questo problema è che comunque, per quanto Elio Vittorini sia un personaggio irrisolto, è uno scrittore riuscito: e tanto basta.
