Luciano Floridi è una delle voci più autorevoli da ascoltare per provare a comprendere meglio il mondo in cui viviamo e il tipo di società che stiamo costruendo. Floridi è filosofo contemporaneo e professore ordinario di Filosofia e Etica dell’informazione all’Università di Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab. Nel 2014 ha scritto un libro, La quarta rivoluzione, pubblicato in Italia nel 2017 da Raffaello Cortina Editore, in cui sostiene che i confini tra vita online e offline stiano sparendo, lasciando il posto a un mondo onlife, sempre connesso. Floridi chiama questa rete di connessioni infosfera.
Si tratta di un cambiamento epocale, a cui il filosofo attribuisce la stessa importanza che hanno avuto altre tre rivoluzioni in passato: la rivoluzione copernicana (la Terra non è al centro del Sistema Solare), la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin (l’uomo non è diverso dalle altre specie animali) e gli studi di Sigmund Freud sulla psicanalisi (non sappiamo tutto della nostra mente, perché esiste l’inconscio). La quarta rivoluzione, che dà il nome al libro, è costituita dal lavoro di Alan Turing. «Turing ci ha deposto dalla posizione privilegiata ed esclusiva che avevamo nel regno del ragionamento logico, della capacità di processare informazioni e di agire in modo intelligente. Non siamo più gli indiscussi padroni dell’infosfera», scrive Luciano Floridi nel suo libro. theWise lo ha intervistato per cercare di capire più a fondo quale sarà il ruolo del digitale nel mondo di domani.

La prima domanda che le pongo riguarda un tema che mi ha incuriosito durante tutta la lettura di La quarta rivoluzione. La società che stiamo costruendo è iperstorica, basata sulle ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e popolata da organismi informazionali chiamati inforg. Bisognerà attendere un completo ricambio generazionale per considerare compiuto il passaggio nell’infosfera?
«Queste transizioni così profonde attraversano una prima fase più rivoluzionaria e drammatica – in inglese si definirebbe “disruptive” – in cui la generazione attuale deve fare i conti con un cambiamento radicale. Le generazioni future, quelle che non avranno vissuto il passaggio ma conosceranno solo il punto di arrivo, lo daranno per scontato. Oggi la percezione del cambiamento ci appare ovvia, ma quando la transizione verso l’infosfera sarà completata potremo guardare al passato solo con una prospettiva storica.
Immaginiamo un emigrato italiano che arriva a New York. Per lui, di prima generazione, il contrasto con il passato che ha vissuto resterà per sempre straordinario. Per i suoi figli e i suoi nipoti questo contrasto non c’è più, resta la memoria. Credo che la transizione sarà completa quando la consapevolezza della transizione sarà memoria, e ci vorrà ancora qualche decennio. È solo quando siamo consapevoli della transizione che siamo in grado di aggiustare il tiro e correggere ciò che non funziona».
Privacy e memoria
La privacy è uno dei punti su cui il dibattito è molto aperto, ad esempio. C’è un passaggio del suo libro che mi ha colpito: «Accettiamo l’idea che essere online sia uno degli aspetti meno privati della nostra vita». Come cambia la percezione della privacy nell’era onlife? Crede che il livello di consapevolezza che abbiamo riguardo alle nostre attività su Internet sia sufficiente?
«Quello sulla privacy è un discorso particolarmente complicato, reso ancora più difficile dal fatto che noi abbiamo una concezione della privacy sviluppata in età analogica e che non si sovrappone bene alla concezione della privacy nell’età digitale. Il dibattito inizia alla fine dell’Ottocento e parte con il piede giusto, per l’epoca, perché la privacy veniva intesa in termini spaziali: il mio spazio, la mia proprietà, la mia casa. Riguardava dei confini fisici. Quest’idea è semplicemente inadeguata nel ventunesimo secolo, perché oggi abbiamo problemi come la condivisione dei dati, dal DNA alle foto con i compagni di scuola. Tanto più l’informazione diventa condivisa, quanto più e difficile mettere dei paletti che delimitino il proprio spazio.
«A questo presupposto si aggiungono due operazioni che abbiamo effettuato nel ventunesimo secolo. Per prima cosa abbiamo sganciato la legge dalla territorialità – oggi parlare di privacy in termini geografici è fuori luogo. Dopodiché abbiamo agganciato l’identità personale alle informazioni sull’individuo, ciò che a livello europeo è chiamato data subject. Questo è il fulcro della questione: significa che dobbiamo reinterpretare la privacy in termini di informazione e farne una questione di identità. Solo così si può comprendere il concetto di privacy in pubblico, che nel vecchio modello è inconcepibile. Nell’ambiente digitale non ci sono confini spaziali e noi siamo costituiti dalle nostre informazioni. Dire che “i giovani di oggi non hanno il senso della privacy” solo perché ritengono normale condividere tante informazioni sulle piattaforme sociali, per esempio, significa non avere colto il cambiamento. Provate a chiedere loro di farvi vedere che musica ascoltano sul cellulare: difficilmente accetteranno.
Oggi difendiamo e affermiamo la nostra identità in maniera diversa rispetto a un secolo fa e siamo più attenti a questioni che fino a ieri non erano prese in considerazione. La privacy oggi si costituisce su più livelli, che richiedono gradi di protezione differenti. Per esempio, il fatto che qualcuno sappia quale autobus ho preso non è necessariamente una invasione rilevante nella mia privacy. Conoscere, invece, dove sono andato, perché, e con che frequenza mi reco in quel posto è un altro discorso e merita un’attenzione diversa».
La prossima domanda si collega a questo concetto. È quasi impossibile eliminare le tracce di ciò che facciamo online, in particolare sui social network. Tuttavia, negli ultimi anni, gli strumenti di condivisione a tempo – prima Snapchat, poi le stories su Instagram e, di recente, i fleets su Twitter – stanno acquisendo una popolarità sempre maggiore. Esiste una correlazione tra questa tendenza e la cancel culture, ovvero l’allontanamento di qualcuno da un ambiente per via di qualcosa che ha pubblicato su Internet, magari dieci anni prima?
«Sì, perché noi siamo in grado di registrare l’informazione ma non il contesto in cui viene prodotta e consumata. E poiché il contesto è ciò che ci permette di interpretare correttamente l’informazione, abbiamo due possibilità: riprodurre il contesto o eliminare l’informazione. Questo punto è legato al dibattito sul diritto all’oblio. Sono stato coinvolto in prima persona nella commissione di Google sul tema e nella discussione il problema della contestualizzazione è emerso in maniera molto forte. Alcuni tendono a generalizzare con esclamazioni come “non si può cancellare la storia”. Nessuno sta dicendo questo. Si tratta invece di salvaguardarla, proprio perché la storia si può comprendere solo grazie al contesto. Una foto pubblicata su Facebook a quindici anni mentre si balla a torso nudo in discoteca può riemergere trent’anni dopo, quando chi l’ha postata è manager di una azienda. In questi casi quello che succede è che il recupero di quella immagine la trasporta nel contesto di oggi, generando imbarazzo e fraintendimenti. È successo, ad esempio, al primo ministro canadese.
Non si tratta di dimenticare, ma di avere un buon rapporto con la memoria. È un operazione che in inglese si chiama closure, che io definisco come “remembering without recalling“. La memoria non viene cancellata, ma non viene nemmeno richiamata in continuazione. La sedimentazione della memoria è qualcosa che il mondo digitale non facilita, pertanto servono strumenti nuovi. È qui che nasce il successo della condivisione a tempo. Se non posso essere certo che ciò che pubblico rimanga per sempre aderente al proprio contesto, allora meglio farlo durare tanto quanto dura il contesto stesso».
A questo riguardo, c’è un aspetto delle ICT che mi affascina molto, quello del loro ruolo come “guardiane della memoria”. Personalmente conservo una notevole quantità di dati su di me e su cui ho il controllo diretto, ma ci sono anche molte informazioni che si trovano su Internet e che non potrei cancellare facilmente, se volessi. Quando non ci saremo più queste informazioni probabilmente resteranno e ci conferiranno una sorta di immortalità digitale. In che modo gestiremo le nostre identità online, in futuro?
«Innanzitutto sarei molto cauto nel parlare di immortalità per tutti, perché non credo che sarà così. Siamo tanti miliardi di persone sulla Terra, molte di queste non hanno nemmeno mai visto un cellulare, quindi bisogna fare attenzione a generalizzare. Non perché sia sbagliato, ma perché così facendo ignoriamo quanto sia diverso il mondo. Ricordiamoci che non esiste neanche l’immortalità fisica: ogni novantanove anni il posto nel cimitero in cui si è seppelliti dev’essere rinnovato e se nessuno lo reclama quello viene svuotato e rivenduto, e chi c’era dentro sparisce.
Sicuramente la memoria oggi è più persistente e pone nuovi problemi, per esempio che cosa fare con i dati dei morti. Sta nascendo una industria per la gestione dei cosiddetti “resti digitali”. Ho analizzato il fenomeno assieme a un mio dottorando in un articolo pubblicato su Nature. Prima o poi su Facebook il numero di profili morti supererà quello degli utenti vivi, è un fatto. Ora, nessuno sa come “imbalsameremo” tutti quei dati, per ora si tratta di una gestione esclusivamente economica, legata al mercato. È qualcosa di cui abbiamo ancora poca consapevolezza, ma di cui dovremo iniziare a occuparci. Ad esempio, con un mio studente ho proposto di lavorare sulla falsariga del codice etico che viene applicato nei musei per tutelare i resti umani. Credo che noi, che viviamo dalla parte privilegiata del digital divide, resteremo in questo spazio digitale più a lungo, certo. Ma il digitale non è solo memoria, è anche cancellazione. Basta un click. Bisogna capire come questo continuo fluire di informazioni si sedimenterà in un mondo digitale “storico”, che noi oggi non siamo ancora in grado di gestire».
Intelligenze artificiali
Ci sono state, negli ultimi anni, novità rilevanti riguardo al progresso delle intelligenze artificiali in grado di superare il Test di Turing? Ho provato a chattare con Mitsuku, un chatbot che ha vinto cinque volte il Premio Loebner, e il risultato mi sembra ancora molto lontano dall’essere soddisfacente…
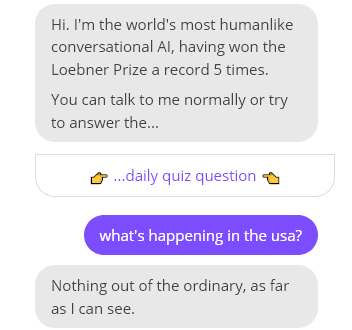
«Le intelligenze artificiali di quel tipo sono semplicemente dei giocattoli, non hanno fatto nessun passo avanti da quando abbiamo iniziato a costruirle negli anni Sessanta. Sono cambiate solo le interfacce, un po’ più furbe e ingannevoli, ma è sufficiente porre una domanda che esce dall’interazione ordinaria per rendersi conto di avere a che fare con un computer. È come parlare con una persona che ha imparato una lingua troppo tardi e non riesce a capire i dialetti di quella lingua. Appena la conversazione va oltre il semplice “Come ti chiami? Come stai?” il crollo è verticale».
L’ostacolo da superare, quindi, è ancora di tipo semantico.
«Ci sono due approcci. Uno, che non si dà pace, è appunto quello del Premio Loebner. Certi colleghi non rinunciano all’idea che a forza di aggiungere sintassi prima o poi la semantica migliorerà. Buona fortuna. Ma zero più zero fa sempre zero! Se si parte da zero semantica non si arriverà mai alla semantica. Se questo approccio funzionasse e ci fosse una macchina in grado di superare veramente il test, adesso ci troveremmo in un altro universo.
Il secondo approccio, invece, è molto più realistico e si basa su una intelligenza artificiale che intelligente non è, né le interessa esserlo. Non sfrutta tanto la logica matematica (“se x, allora y”), quanto la statistica e l’analisi di immense banche dati. Correlazione, non più deduzione. Cioè: a furia di far vedere a un computer migliaia di fotografie di gatti, la macchina inizierà finalmente a riconoscere quando c’è un gatto in una immagine. Questo approccio non è una novità – già negli anni Novanta facevo corsi di filosofia dell’intelligenza artificiale sulle reti neurali e le prime implementazioni risalgono agli anni Cinquanta – ma solo oggi possediamo la potenza di calcolo e la massa di dati richieste affinché l’algoritmo funzioni. Questo è il percorso che farà progredire le intelligenze artificiali, tutto il resto non ha futuro».
E gli assistenti domestici come Alexa e Google Home dove si posizionano in questo scenario?
«Ecco, questi casi rappresentano bene un aspetto interessante: le interfacce. Gli assistenti domestici ci aiutano a imparare qual è la modalità interattiva vocale più intelligente e più accattivante per gli utenti. Ma questo è uno studio di psicologia umana, non ha più niente a che fare con l’intelligenza artificiale in senso stretto. Impariamo a parlare con questi sistemi, ci adeguiamo a loro, un po’ come quando balbettiamo rumori senza senso a un neonato nella speranza di farlo ridere. Riguarda l’esperienza tra me e la macchina, e in quale modo la macchina può manipolarmi al meglio: tono di voce, vocabolario, interazione…».
Crede che il settore della difesa militare continuerà a guidare il progresso delle ICT, come è stato fino ad oggi?
«Non credo. Resta vero il fatto che la difesa continua ad avere a disposizione un budget enorme, tuttavia ci sono altri due settori – uno è già emerso, l’altro sta emergendo – che diventeranno i nuovi motori dell’innovazione nel digitale. Uno è quello della salute, che ha un budget molto superiore, a livello mondiale, di quello della difesa [nel 2017 a livello mondiale sono stati spesi 7,8 trilioni di dollari per la salute e 1,7 trilioni per la difesa, N.d.R.]. Il secondo è quello dell’intrattenimento, dalle piattaforme di streaming ai videogiochi online, alle app, alla realtà virtuale. Parliamo di un fenomeno enorme, il cui volume d’affari cresce senza sosta da anni [nel 2018 l’intero settore ha registrato ricavi per 2,1 trilioni di dollari, N.d.R.]. L’innovazione arriverà da queste tre forze, ciò che cambia è la commercializzazione dei risultati. Mentre la ricerca militare è per sua natura segreta – il settore tende a non divulgare le proprie scoperte – la sanità commercia e condivide subito l’innovazione. Un atteggiamento ancor più evidente nel mondo dell’intrattenimento, dove peraltro il budget a disposizione proviene principalmente da aziende private e non dagli Stati».
L’importanza della politica

È da poco uscito il suo nuovo libro, Il verde e il blu, sempre per Raffaello Cortina Editore. Il volume prosegue lo studio sull’infosfera e sulla quarta rivoluzione, questa volta concentrandosi sulla politica e offrendo alcuni suggerimenti, che lei chiama “idee ingenue”. Qual è il modello che propone?
«Il libro è nato nel 2017 prima delle elezioni politiche, e nella mia idea iniziale voleva essere un contributo intellettuale al dibattito pubblico. In realtà, nel corso della sua stesura, è diventato un progetto più ambizioso. Il verde e il blu propone un ripensamento dei concetti di base della politica, per capire se nel ventunesimo secolo certi modi di fare e certe abitudini abbiano ancora senso. Perché negli ultimi decenni la società è cambiata molto e la politica deve essere in grado di adattarsi a questo cambiamento».
E come si soddisfa questa necessità di cambiamento?
«Il cambiamento della politica deve essere ontologico. La politica non dev’essere più una disciplina che si occupa solo di cose, ma deve diventare una disciplina che si occupa soprattutto di relazioni. La battuta nel libro è: “non res publica, ma ratio pubblica“. Il dibattito sull’immigrazione, ad esempio, è ancora impostato in termini novecenteschi da persone che parlano di cittadini e non di cittadinanza. Oppure l’Europa: se ragioniamo in termini di relazioni e non di cose, l’Unione Europea non è più un progetto basato sui confini, ma sui valori. Di conseguenza l’Ungheria, che non condivide i nostri valori, può uscire, e il Canada può entrare, anche se geograficamente è lontano.
Anche l’economia deve fare i conti con questo presupposto: è ora di smettere di basare la politica economica sulla produzione di cose. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’80% dei lavoratori è impiegato nel settore terziario. Si tratta quindi di immaginare un’economia basata sulle relazioni, sulle esperienze, sul prendersi cura del mondo e delle persone. Del resto, nella domanda precedente abbiamo indicato la sanità e l’intrattenimento come due dei settori che guideranno l’innovazione digitale…».
Quello che vedo, da millennial, è una classe dirigente che non è adeguata a rispondere alle sfide di questo tempo. Le mancano gli strumenti per comprendere la materia e di conseguenza la politica produce leggi incomplete, che generano più danni che benefici.
«Per non parlare delle leggi non fatte. Se, ad esempio, manca una legislazione robusta sull’e-commerce, il settore non cresce. L’Italia non è tra i primi dieci Paesi al mondo per commercio online. Al decimo posto c’è il Brasile. Come è successo? Non è che l’Italia non sia un Paese esportatore. Però disinteresse, distrazione, incompetenza e leggi non fatte hanno portato a questo. Allora, per tornare al principio della nostra conversazione, se oggi potessimo mettere al potere qualche giovane competente piuttosto che un cinquantenne che non è in grado di giocare a questo gioco (e parlo da cinquantenne), sarei decisamente più fiducioso. Le persone competenti in Italia non mancano, ma non vengono sfruttate nel modo giusto».
Di recente è stato nominato membro dell’Ethics Advisory Board for NHSx COVID-19 app, il comitato indipendente che ha il compito di giudicare le implicazioni etiche delle app di tracciamento dei contatti in Gran Bretagna. Qual è il contributo che ha dato al gruppo di lavoro? E, più in generale, qual è la sua posizione riguardo alle app di contact tracing?
«Il mio contributo è quello di un filosofo, quindi più intellettuale e di strategia che tecnico. Non posso entrare nel dettaglio perché si tratta di argomenti confidenziali, ma in generale sono contento di ciò che stiamo facendo. Il percorso che abbiamo intrapreso è buono, ma la premessa è che la app bisogna farla. È su questo che io ho qualche dubbio: si dà per scontato che di questa app ci sia bisogno. Da un lato mi piace l’idea, perché mette insieme il meglio della tecnologia digitale a sostegno dell’ambiente.
È la prima volta che succede su così larga scala e non sappiamo come andrà a finire. I risultati che stiamo ottenendo non sono pessimi; non sono nemmeno quelli che ci aspettavamo, ma questo fa parte della sperimentazione. Il verde e il blu hanno bisogno del collante sociale fatto di fiducia nelle istituzione e solidarietà. Su questo c’è moltissimo da fare. Tuttavia, il compito che abbiamo come Board è dire che cosa pensiamo di questa app, non delle app contact tracing in generale. C’è una bella differenza. Io forse oggi l’app la ripenserei del tutto».
Leggi anche: Contact tracing e identità digitale: un’occasione per crescere.
In conclusione, qual è il ruolo del digitale nella società che ci aspetta?
«Credo che il digitale possa dare una mano a risolvere grandi problemi, ma deve funzionare meglio il sistema sociopolitico. Oggi sfruttare il digitale per contrastare una pandemia significa affidarsi alle grandi aziende come Google e Apple. La politica e la società dovrebbero riappropriarsi di questo onere, perché le forze del mercato hanno un approccio sbilanciato verso il profitto. È una logica che non mi dispiace, intendiamoci: il profitto genera ricchezza. Tuttavia non si prende cura della distribuzione, non ha alcuna forma di responsabilizzazione – se non quella imposta dalla legge – e fa malissimo all’ambiente. Su questi tre punti gli Stati dovrebbero intervenire seriamente e giocare da protagonisti. Se poi le aziende del web vorranno partecipare saranno loro a essere nostre ospiti, non il contrario. È un altro mondo, lo so, però è il mondo in cui vorrei vivere».
