Non è sempre facile approcciarsi ai mestieri considerati del futuro e trovare libri su cui iniziare a costruire la propria conoscenza. In Italia è quello che succede per la User Experience Research, spesso abbreviata in UX Research. Sembra un settore nuovo e poco conosciuto, ma in realtà pervade numerosi campi in cui la società umana si muove. Infatti, ogni volta che un essere umano risponde a uno stimolo, di fatto vive un’esperienza. In parole semplici, la UX Research indaga questa risposta.
Quindi cosa fa lo/la UX Researcher? E perché può rivelarsi una figura chiave nel processo di produzione di esperienze, principalmente online?
TheWise Magazine ha incontrato Francesca Bonazza e Matteo Tibolla, due UX Researcher e professionisti, che hanno pubblicato il libro User Experience Research. Scienza e principi guida per esperienze online efficaci edito da Flaco Edizioni, che abbiamo avuto piacere di leggere.
Molto più di un manuale
User Experience Research. Scienza e principi guida per esperienze online efficaci si propone di raccontare esperienze e raccogliere metodologie. Racconta come Matteo e Francesca si sono approcciati alla UX Research e come il loro percorso si è evoluto, caso dopo caso, permettendo loro di definire una metodologia sempre più scientifica. È uno dei pochi libri in italiano scritti da ricercatori italiani sull’argomento, e il suo valore sta nel dare un taglio pratico a una disciplina che sembra ancora fumosa.
207 pagine divise in sette capitoli che restituiscono un racconto appassionato del settore e della propria crescita come ricercatori. L’insieme di esperienze personali e di metodologia, racchiusa nei capitoli più manualistici, rende User Experience Research un libro unico nel suo genere, che permette di andare in profondità e fare proprio l’approccio alla ricerca che può permettere di avere risultati concreti.
Lasciamo parlare gli autori e scopriamo il percorso che li ha portati alla scrittura del libro.


Come vi siete approcciati alla UX Research? Qual è in breve il vostro percorso? Cosa significa fare UX Research in Italia?
Francesca
«Abbiamo iniziato nel 2017, avviando alcuni test di usabilità nel settore bancario, sia per la parte desktop che mobile. Ci siamo mossi fin da subito applicando due principi. Il primo è quello delle scienze comportamentali, già presente nel nostro bagaglio di conoscenze perché ci occupavamo di analisi e ricerca sull’utente, anche se in altri contesti. Il secondo invece è quello del buon senso, come raccontiamo anche nel libro. Quando si tratta di UX Research è la forma mentis, l’approccio che si ha, a fare la differenza: e questo aspetto è in parte mosso dal buon senso. Il buon senso però non nasce dal nulla: si costruisce sperimentando, facendo autocritica su ogni lavoro che fai, studiando tanto e ponendoti delle domande per raggiungere una consapevolezza sempre maggiore e quindi migliorare la metodologia.
Fare UX Research oggi? Il settore si è evoluto rispetto a qualche anno fa, diventando più complesso e coinvolgendo sempre più figure professionali. Una volta c’era una sola figura, quella dello sviluppatore web, a dare vita a un’interfaccia. Ora ci sono designer, copywriter, UX Researcher… occorre imparare a lavorare in team così da arrivare a strutturare l’esperienza migliore per l’utente e vincere sui competitor, che ora sono davvero tanti. Questo lo si può fare solo in un modo: ascoltando davvero chi vive l’esperienza, dando valore a essa e al suo significato per l’utente».
Matteo
«Fare UX Research in Italia significa fare un lavoro che, al momento, fanno in pochi. Non è una materia troppo conosciuta e spesso è delegata a chi si occupa di altro, quindi viene trattata quasi come secondaria. Anche qui si sta comunque raggiungendo una consapevolezza più strutturata e profonda, infatti sono convinto che in un futuro non troppo lontano la UX Research e la sua metodologia saranno applicati anche ad altri campi, non solo a quello del digitale. Come diceva Francesca, è nella forma mentis che risiede il potenziale della UX Research e, per ottenere risultati, occorre abituarsi a chiedere e a confrontarsi con chi l’esperienza la vive. E questo è vero per tutte le esperienze, come dicevamo. L’abbiamo capito testando e provando quanto questi aspetti siano fondamentali e lo approfondiamo ampiamente anche nel libro, presentando casistiche, aneddoti e spunti vari».
User Experience Research. Scienze e principi guida per esperienze online efficaci non è esattamente un manuale. Come lo definireste? Qual è stato il vostro approccio nella stesura del libro? In poche parole, cosa deve aspettarsi chi deciderà di comprarlo?
Matteo
«È un libro un po’ a sé che non ci piace chiamare manuale, perché non volevamo riproporre i classici manuali che appunto già esistono, anche se in italiano non ce ne sono molti. È un racconto di esperienze in cui, con sincerità e senza vergogna, raccontiamo quello che abbiamo fatto, con successi e fallimenti, e descriviamo come abbiamo imparato dai nostri errori e perfezionato, di volta in volta, la metodologia. E devo ammettere che i primi feedback che abbiamo avuto in questo senso sono stati positivi: è un valore che viene riconosciuto al nostro testo. C’è poi anche una componente di manualistica, dove è possibile apprendere tutte le nozioni per eseguire un test di usabilità in modo preciso e il più scientifico possibile.
Per quanto riguarda la stesura, è stato tutto molto naturale: volevamo trasmettere il nostro percorso per far capire come e perché siamo arrivati dove siamo, per questo anche i casi studio presentati nel libro si rivelano fondamentali. Il target di riferimento è vario: chi già lavora nel settore, chi ci si sta approcciando, chi è curioso, chi lavora in settori collaterali, imprenditori, professionisti del marketing o sviluppatori. Chi deciderà di leggerlo deve aspettarsi una guida pratica».
Francesca
«Concordo nel definirlo un racconto di esperienze, perché poi di fatto è quello che abbiamo voluto trasmettere. Per noi è importante che chi legge possa ritrovarsi in situazioni reali che ha vissuto o vivrà: quello che leggerà potrà applicarlo e contribuirà a creare la forma mentis di cui dicevamo prima, quella che ogni UX Researcher dovrebbe avere. Ovviamente ci sono diversi modi per fare usabilità, per approcciarsi all’ascolto delle persone, dipende da ciò che si deve progettare».
Nel libro sottolineate che, nelle aziende italiane, spesso non c’è consapevolezza sul valore della UX Research e che la cultura digitale degli imprenditori non è ancora pronta per un certo approccio. Come mai secondo voi?
Francesca
«Questa è una domanda molto bella che meriterebbe almeno tre giorni di workshop, ma provo comunque a rispondere. Diciamo che l’imprenditore, se non si fida del consulente, dovrebbe almeno ascoltare il suo cliente. Chi è titolare di un’impresa giustamente vuole dirigerla secondo le proprie idee, aspirazioni e conoscenze. A volte succede che chi nell’azienda lavora nei settori più operativi, oppure un consulente, si accorga di certe criticità, ma non è sempre facile trasmetterle a chi prende le decisioni. Se invece si raccolgono le informazioni nel profondo interrogando la persona a cui è destinato il prodotto finale, diventa più difficile ignorare i suggerimenti. Ed è una leva strategica per far prendere le decisioni giuste a chi si occupa del management: i dati raccolti si basano sulle esigenze reali del mercato, non su impressioni o sentito dire.
Un’altra considerazione che mi sento di fare, personalissima e basata solo sulla mia esperienza, è che spesso nelle PMI si tende a lavorare in emergenza: accade così di trovarsi a compiere scelte velocemente, senza il tempo di analizzare e approfondire, per poi dover correggere il tiro in corsa o trovarsi ad aver commesso un errore, ad esempio in termini di investimento o strategia».
Matteo
«La domanda è difficile e sarò breve per non incappare in bias. Nella mia esperienza da consulente posso dire che esistono tre livelli in cui ci si approccia all’usabilità.
Il primo livello è di chi ancora non ha cultura sull’argomento, quindi non ha gli strumenti per capire il valore di un test di usabilità. Il secondo è di chi, come le startup, lavora nel digitale e spesso produce nuove piattaforme. Qui il valore viene riconosciuto e c’è anche conoscenza in materia, ma spesso i test sono portati avanti non da UX Researcher e quindi non sempre si ottengono dati mirati o puliti, perché magari non vengono poste le domande corrette oppure non si ha consapevolezza di certi bias. L’ultimo livello invece è di chi conosce il settore, sa quello che vuole e ha il giusto budget per avvalersi dei professionisti di settore. E per fortuna ci sono sempre più figure in questo terzo livello!»
Parlate ampiamente di bias cognitivi e, nel capitolo 2, approfondite anche l’importanza di un uso etico degli stessi. Ci aiutate a capire cosa sono e perché sono fondamentali?
Matteo
«I bias sono gli errori che commettiamo quando facciamo una scelta o prendiamo una decisione. Di fatto ci sono due tipi di bias: quelli che possiamo sfruttare in modo etico per far compiere un’azione in modo più fluido e i bias in cui possiamo incappare noi ricercatori, col risultato di avere dati distorti. Faccio un esempio per farmi capire meglio: le persone intervistate da ricercatori vogliono farsi vedere al meglio e quindi c’è il rischio che diano informazioni non proprio vere per “accontentare” il ricercatore. E questo genera dati non attendibili».
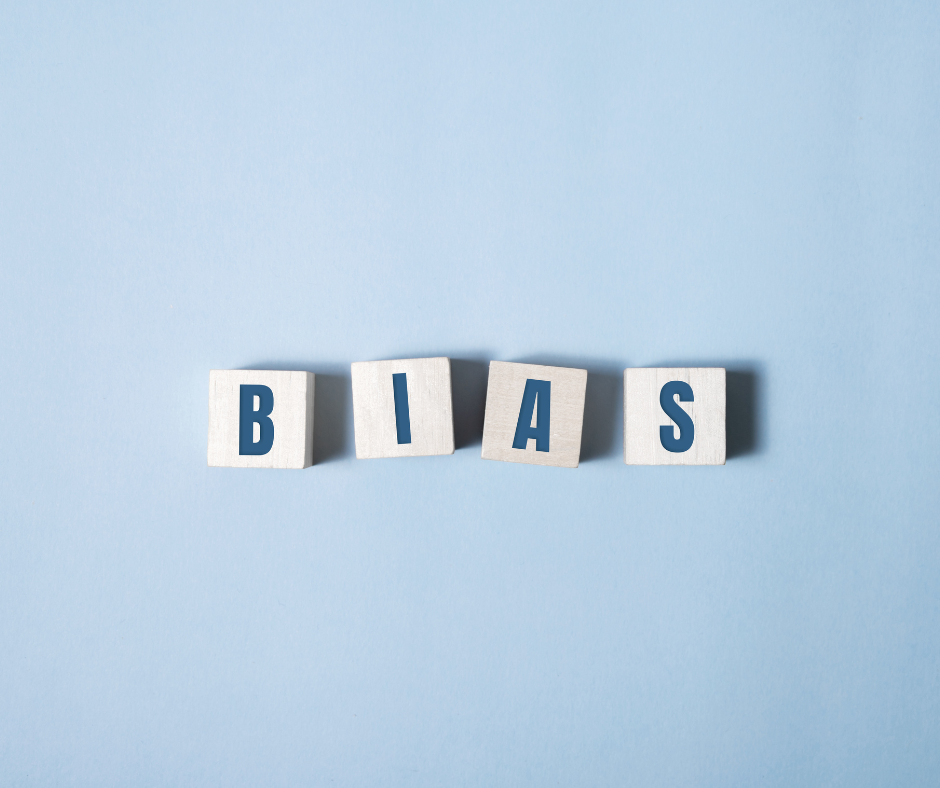
Francesca
«Per non incappare in questi bias nel tempo abbiamo modificato le istruzioni per chi avrebbe dovuto compiere il test. Specificare che il sito o comunque l’oggetto del test non era stato creato da noi ha aiutato molto: i soggetti del test si sono sentiti più liberi di essere sinceri.
I bias sembrano una cosa arcinota da una parte ma sconosciuta dall’altra. Spesso vengono usati senza nemmeno esserne consapevoli. Usarli in modo etico significa avvalersene per dare alla persona destinataria del prodotto ciò che vuole, un vantaggio che interessa loro davvero, non per manipolare o raggirare il cliente.
Un esempio può essere il bias dell’autorevolezza. Se hai un ecommerce e inserisci PayPal come sistema di pagamento rassicuri chi deve compiere l’azione perché PayPal è riconosciuto come affidabile, e se tu l’hai nel sito probabilmente verrai percepito come più affidabile. Questo è un uso etico di un bias cognitivo».
Quello che emerge dal vostro lavoro è che gli aspetti emotivi, relazionali e comportamentali sono fondamentali, non solo nell’ambito UX. Eppure, per molti professionisti collaterali al settore gli esseri umani sono esseri estremamente razionali che faranno sempre la scelta più logica. Come mai secondo voi gli aspetti emotivi sembrano essere ignorati? Voi invece, come li inserite nel vostro approccio?
Matteo
«Principalmente per abitudine. Veniamo cresciuti dando per scontata la razionalità dell’essere umano e studiando materie scientifiche che mettono al centro la ragione e la logica. Un altro motivo è che non ci piace ammettere di essere macchine emotive. È più facile vederci come macchine pensanti che scelgono solo in base alla razionalità. Anzi, spesso ci sentiamo a disagio quando siamo comandanti dalle emozioni, ci definiamo “fuori controllo”.
Questo approccio lo trasliamo anche quando produciamo contenuti destinati ad altri: non vogliamo ammettere che il destinatario possa usufruirne in base alle emozioni che gli suscita. Analizzare le emozioni e dar loroi un significato scientifico valido, ad esempio, per un test di usabilità è estremamente complesso ed è anche uno dei focus del nostro libro. Si può fare in molti modi e il più semplice è quello di chiedere quali emozioni si sono provate. Già da questo primo passo possono nascere scoperte davvero sorprendenti».
Francesca
«Riagganciandomi a quanto appena detto, chiedere sembra una cosa banale, eppure lo fanno davvero in pochi. Certo, ci sono strumenti avanzati che permettono di riconoscere i movimenti facciali associati a un’emozione, ma la questione è più semplice e si può gestire in modo diretto, come diciamo nel libro. Spesso sarebbe sufficiente testare le nostre convinzioni per scoprire che spesso usiamo una logica che non è oggettiva, ma è condivisa solo da un determinato gruppo sociale».
Il vostro libro alterna momenti di riflessione professionale a capitoli più pratici. Entrambi le componenti contribuiscono a dare una visione onesta e pratica della UX Research in Italia. Che consigli dareste ai futuri professionisti del settore?
Francesca
«Mi è capitato qualche volta di dare consigli a chi per la prima volta si approccia al settore: ovviamente sono soggettivi e non sono validi per tutti. Ciò che aiuta è avere una conoscenza trasversale del settore, seppur in superficie. Il nostro lavoro – quello dello UX Researcher – è fatto di interconnessioni tra gruppi multifunzionali e di relazioni con altri professionisti. Un altro consiglio che do perché è un’esperienza che io non ho fatto è di lavorare in ambienti strutturati, quindi in una big azienda o agenzia, che ti permetta di vedere tutte le aree aziendali e capire al meglio chi sei tu come professionista».
Matteo
«In realtà, anche fare esperienza in una piccola azienda non è poi così male. Noi siamo partiti così e devo dire che abbiamo messo le mani in diversi ambiti che ci hanno formati.
Comunque, io trovo che la figura dell UX Researcher sia simile a quella del sociologo. Probabilmente perché ho questa formazione e mi viene spontaneo fare questo parallelismo. Entrambi hanno la fortuna di essere una figura ibrida, in cui avere conoscenze in più settori è necessario. Se sei sociologo devi saperne un po’ di storia, di economia, di psicologia e così via. Lo stesso se sei UX Researcher: ovviamente devi sapere fare ricerca, ma devi anche saperne un po’ di design, un po’ di psicologia anche qui, un po’ di neuroscienza, di copywriting.
Questo mi porta al consiglio che per me è fondamentale anche se può sembrare scontato: leggere molto, continuare a studiare i testi di settore, in italiano e inglese. Un spunto interessante per iniziare a fare questo lavoro può essere quello di proporre una ricerca in ottica UX alla realtà in cui già si lavora. Magari non verrà subito una ricerca ottimizzata, ma sicuramente verrà fuori un progetto interessante che aiuterà a capire come muoversi al meglio rispetto a un’interfaccia».
Ultima domanda: secondo voi, nel medio periodo, come cambierà la considerazione della UX Research in Italia?
Francesca
«Secondo me si vedrà una progressiva codifica delle tecniche e delle modalità con cui fare UX Research. Vedo che ora l’approccio alla materia è molto più tecnico e normato. Da una parte è un bene, perché permette di operare su basi molto più solide. Allo stesso tempo mi lascia un po’ dubbiosa.
Come abbiamo accennato per tutta l’intervista, per noi è la forma mentis a fare la differenza, pertanto se l’approccio diventerà più tecnico, mi chiedo: quanto spazio rimarrà per applicare la forma mentis appresa, e cioè quella di rimanere aperto, saper valutare la relazione con chi sta eseguendo il test, oppure saper trovare il modo per capire cosa cosa provano le persone in un determinato contesto.
Auspico che la normazione della disciplina non vada a scalfire questo approccio, anche un po’ critico rispetto agli e che sempre necessita di una giusta dose di personalizzazione in base a obiettivi, target, settore, categoria merceologica, strumenti digitali e così via».
Matteo
«Vivere un’esperienza e provare delle emozioni rispetto a essa non fa parte solo del mondo digitale, anzi. Credo che in un futuro non troppo lontano la UX Research sarà sempre più applicata, a numerosi ambiti, come il packaging, video, giochi…insomma, rispetto a qualsiasi contesto dove sono presenti stimoli a cui l’essere umano deve rispondere».
